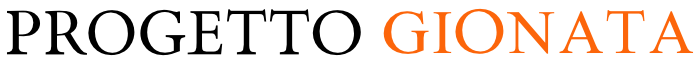Il gioco che unisce. A Firenze dal 26 al 27 aprile con IN/VISIBIL3

Dialogo di Katya Parente con le organizzatrici di IN/VISIBIL3
Giocare non è solo un passatempo, come sappiamo bene noi appassionati. Può funzionare, anzi, da veicolo di messaggi estremamente importanti. E IN/VISIBIL3, evento che si terrà a Firenze il 26 e il 27 aprile, ne è la prova. Ecco come hanno risposto ai nostri quesiti le sue organizzatrici.
Cos’è IN/VISIBIL3?
IN/VISIBIL3 è una convention che da tre anni porta le visioni transfemministe, intersezionali e queer dentro il mondo ludico, continuando la strada di altre realtà che ci hanno precedute. Ogni anno proponiamo con l’aiuto delle persone ospiti e di chi partecipa un insieme di panel, laboratori, attività ludiche e lunghe conversazioni con l’idea di decostruire e rimontare il mondo ludico in modi alieni e imprevisti.
Pur consapevoli delle storture che caratterizzano i mondi ludici, dalla produzione alla commercializzazione agli spazi di socialità dominanti, cerchiamo di portare uno sguardo positivo e indirizzato verso un futuro che preveda spazio e libertà per tutte le comunità marginalizzate.
Qual è il programma di questa edizione?
Il tema centrale di quest’anno è il sesso, che verrà declinato secondo tre aspetti: sessualità, consenso e rappresentazione dei corpi.
Abbiamo deciso di affrontare il complesso tema del sesso perché forse è uno degli argomenti più presenti e insieme meno trattati nel mondo ludico, e che è rappresentato nelle varie modalità ludiche con gradi di elaborazione molto diversi: se ad esempio nel LARP da anni si elaborano strumenti complessi sul consenso, sulla liberazione dei corpi, sulle varie sfaccettature della sessualità umana, il videogioco fuori dalle produzioni indipendenti è ancora dominato da una visione del sesso eteronormata, penetrativa, non consapevole delle dinamiche di creazione del consenso.
Che rapporto c’è tra gioco e inclusività?
Inclusività è un termine utilizzato spesso quando si parla del rapporto tra una determinata realtà e le comunità marginalizzate, ma che troviamo carico di problematicità: crea un soggetto da includere e un soggetto che include, che decide quali siano le norme, cosa sia accettabile e cosa no. In questo senso l’inclusione diventa solo un modo diverso per mantenere le stesse dinamiche di potere che creano esclusione.
Anche per questo l’idea di inclusività ha permesso all’interno delle aziende ludiche di creare una paradossale esclusione: “più inclusivo” diventa un plugin, una cosa accessoria ea sé stante che a un certo punto si può scegliere di aggiungere. Una casella da spuntare per darsi una pacca sulla spalla con la convinzione di aver fatto la propria parte. O, con l’accrescersi di poteri fascisti nei governi occidentali, una casellina da rimuovere dall’elenco degli obiettivi da raggiungere.
L’inclusività è diventata anche un modo per premiare comportamenti che non creano tensione o dissenso, che non mettono in evidenza i problemi strutturali della nostra società, andando ad escludere ciò che viene considerato invece come pericoloso: considera alla rabbia delle comunità razzializzate, spesso oggetto di critica e controllo anche in spazi che si professano inclusivi.
Con questa immensa premessa, la risposta che ci viene è: un gioco può parlare in modo costruttivo di un gruppo marginalizzato se e solo se quel gruppo viene coinvolto dall’inizio alla fine del processo creativo, non solo negli aspetti narrativi e/o grafici ma anche e soprattutto in quelli di game design.
In che modo l’esperienza ludica può aiutare le persone LGBTQ?
In primo luogo, creando comunità, come dimostrare da più di dieci anni La Gilda del Cassero e le tante altre realtà LGBTQIA+ ludiche sul territorio nazionale. Creare spazi in cui essere sé stess3 in modo più sicuro e non sentirsi più sol3, isolat3.
C’è anche un aspetto di autodeterminazione: potersi vedere in un gioco significa sapere che si ha il diritto di esistere. E dato che il gioco più di altri media crea un’esperienza concreta (la dottoressa Viola Nicolucci ha fatto diversi interventi sul tema), la possibilità di agirsi in uno spazio immaginativo diventa occasione per ascoltarsi e capirsi quando la realtà esterna non è accogliente.
C’è infine, sempre partendo dalla natura esperienziale del gioco, la possibilità di aiutare le persone che non fanno parte della comunità LGBTQIA+ a comprendere meglio gioie e dolori del nostro vissuto. Questa è forse la parte più complicata, perché non sempre la persona non queer che gioca un’esperienza queer riesce a comprendere che non bastano quelle poche ore al tavolo o davanti a uno schermo per capire la complessità delle nostre esperienze (e qui consigliare gli interventi di Bo Ruberg contro gli Empathy Games).
Con questi stessi principi, il gioco può anche ostacolare il benessere di ogni gruppo emarginato: non esiste nulla di neutro, leggero, casual in un gioco. O è costruito in modo consapevole, o rischia di perpetuare stereotipi pericolosi.
Ringraziamo le ragazze per le risposte, ma, soprattutto, per l’impegno e la passione che mettono in questa iniziativa così coinvolgente. Per chi crede ancora che i videogiochi sono solo passatempi, o avesse qualche dubbio in merito, IN/VISIBIL3 li dissiperà tutti. In attesa dell’evento, potrete saperne di più sui loro canali social e su https://www.invisibil3.it