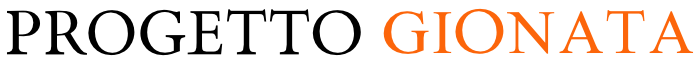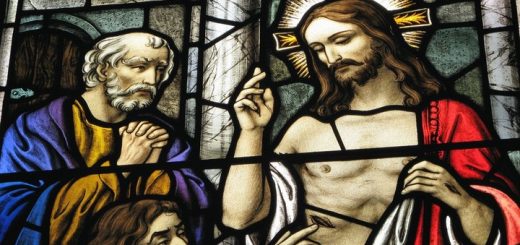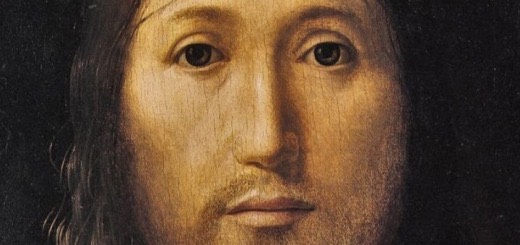La Bibbia e l’Europa. Storia di un rapporto complesso e difficile
 Riflessioni di Paolo Ricca del 19 aprile 2009 tratte da Ecumenici ecumenici.wordpress.com/
Riflessioni di Paolo Ricca del 19 aprile 2009 tratte da Ecumenici ecumenici.wordpress.com/
Direttamente o indirettamente tutta l’Europa è imbevuta di Bibbia, non solo a livello delle elaborazioni culturali, ma anche al livello più spiccio della esistenza quotidiana che ne è determinata, anche senza che ce ne accorgiamo, in molti modi.
Per esempio moltissimi europei, anche se atei, portano dei nomi biblici; le norme di comportamento elementari anche di coloro che non si considerano cristiani sono quelle della Bibbia, codificate in alcuni almeno dei dieci comandamenti.
Personaggi e storie bibliche hanno popolato e popolano tuttora la nostra fantasia. Provengono dalla Bibbia sia grandi visioni e affermazioni di ordine religioso e filosofico (per esempio la nozione del tempo misurato), sia realtà più semplici della vita quotidiana come i proverbi.
Il proverbio “chi cerca trova”, che tutti sanno, è una parola di Gesù, ma in generale chi pronuncia questo proverbio non lo sa e così via. Pensate al ruolo della croce nella storia della fede, e anche dell’incredulità, del nostro continente, fino, ad esempio, al ruolo svolto da personaggi come Adamo ed Eva e la loro storia.
La visione dell’uomo, la cosiddetta antropologia, è sostanzialmente determinata dal racconto della vicenda dei progenitori dell’umanità. Si potrebbe continuare a lungo in questo elenco.
C’è poi tutto il lavoro che è stato compiuto in Europa sulla Bibbia. La Bibbia ad esempio è sempre stata letta in tutte le messe, quanto meno domenicali, da venti secoli a questa parte. Immaginate la quantità di comunicazione del testo biblico: per venti secoli in tutte le messe, e non soltanto nelle messe, tutto questo materiale biblico è stato comunicato e in qualche maniera trasmesso.
Pensiamo al breviario (riservato al clero della confessione cattolica) che è sostanzialmente un insieme di testi biblici (vi sono anche altri testi, ma certamente la gran parte è materiale biblico).
Pensiamo al ruolo dei Salmi nella preghiera della Chiesa e in generale dell’universo religioso europeo, pensiamo all’immenso lavoro compiuto in Europa per la trasmissione del testo biblico, agli innumerevoli manoscritti che hanno inondato l’Europa, che hanno occupato generazioni e generazioni di monaci, in modo particolare, all’immenso lavoro per tradurre, per commentare, per spiegare, per divulgare, per illustrare il testo biblico, pensiamo alla famosa “Biblia pauperum” (Bibbia dei poveri) a partire dal sec. XIII, a questo immenso sforzo per rendere la Bibbia accessibile, tramite pitture murali o su pergamena, agli analfabeti o ai preti che erano appunto poveri, in certe circostanze, per comprare la Bibbia in forma di manoscritto, che utilizzavano questa specie di Bibbia per commentare e raccontare qualche cosa della storia della salvezza.
Alcuni studiosi vedono in questa espressione una allusione polemica ai movimenti ereticali, che proprio in quel periodo facevano della predicazione itinerante, il cui contenuto era essenzialmente la Bibbia (in particolare il Sermone sul Monte), uno dei punti prioritari del loro programma di rinnovamento cristiano.
Sotto questo profilo acquista un valore emblematico il fatto che il primo libro stampato in Europa è la Bibbia. Ora tutto questo lavoro sulla Bibbia in larga parte precede la Riforma protestante, è un lavoro che è avvenuto anche nel tardo medioevo, è avvenuto nel primo millennio. Nella sola Germania, dal 1466 al 1522, quindi nell’arco di sessanta anni, vedono la luce diciotto Bibbie complete in tedesco. Insomma Bibbia ed Europa hanno delle storie inestricabilmente intrecciate.
Ma c’è anche il rovescio della medaglia e cioè una serie di fatti che mostrano come in Europa la Bibbia sia stata incatenata, vietata, bruciata oppure semplicemente ignorata. C’è anche un’Europa che ha avuto paura della Bibbia come se l’avesse temuta e perciò volesse a tutti i costi tenerla a bada.
Quindi il latino è stata la prigione: prima è stata la liberazione e poi è stata la prigione della Bibbia in Europa. È stato necessario liberare la Bibbia dal latino; c’è qui tutta la storia complicatissima, intricatissima delle versioni della Bibbia in lingua volgare proprio per liberare la Bibbia dalla prigione della lingua latina e restituirla al popolo.
Proprio a questo punto, nel momento in cui dalla Bibbia in latino si passa alle Bibbie in lingua volgare, si colloca il divieto, appare sull’orizzonte della storia tutta una serie di divieti.
Il Concilio di Trento
Il Concilio di Trento si occupa della Bibbia in due decreti, dell’8 aprile 1546. Uno è quello in cui si fissano i libri canonici, includendo anche i deuterocanonici, e si afferma che il Concilio riceve con pari atteggiamento di devozione e di pietà, insomma di fede, sia gli scritti biblici fissati secondo il canone del Concilio, sia le tradizioni non scritte, che però lo Spirito Santo o Cristo stesso avrebbero oralmente comunicato agli apostoli e sarebbero state trasmesse attraverso i secoli “come da mano a mano” fino ai nostri giorni, sia per quanto concerne questioni di fede che di morale.
Il secondo decreto che ci interessa è quello in cui si danno diverse norme riguardo alla stampa della Bibbia: si vieta una Bibbia stampata senza l’indicazione della città, oppure con una indicazione inesatta, falsa della città, si vieta di pubblicare una traduzione della Bibbia senza l’indicazione del traduttore, si vieta di smerciare una Bibbia stampata da un’altra città, si vieta il possesso della Bibbia, si vieta insomma un po’ tutto quello che non è sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica.
Si vietava già da prima ai laici la lettura della Bibbia, senza autorizzazione ecclesiastica e senza la presenza di un competente. La Bibbia viene per così dire messa in libertà vigilata. La Bibbia deve essere controllata, non può essere lasciata in mano ai laici, ai credenti, ci deve essere sempre l’occhio della Chiesa che vigila sull’uso della Bibbia nella chiesa.
E così la Bibbia ha cominciata una nuova storia. Dobbiamo parlare di una Bibbia clandestina – siamo in Europa non in Iraq! – di Bibbia contrabbandata, bisogna parlare di Bibbia arrestata, di Bibbia requisita, di Bibbia sequestrata, di Bibbia bruciata. C’è anche la libertà di Bibbia.
Dunque c’è stata anche una caccia alla Bibbia, non è esagerato dirlo, e c’è stato indubbiamente nel nostro passato questo rapporto ambivalente, conflittuale, contraddittorio. La Bibbia viene avvertita come pericolo potenziale, certo come una grande benedizione e come una grande verità purché però non mi sfugga di mano.
Va in qualche maniera tenuta al guinzaglio, l’imprimatur ecclesiastico va posto su ogni traduzione e su ogni spiegazione. Questo per quanto riguarda in particolare l’Europa cattolica.
Bibbia e protestantesimo
Se diamo uno sguardo all’Europa protestante, la situazione è ovviamente abbastanza diversa anche se è abbastanza tipico, io credo, il fatto che le Società Bibliche nascano accanto alle chiese e non come opere delle chiese stesse.
Certo i credenti che le compongono sono membri delle chiese, ma è tipico che la Società Biblica in quanto tale sia un’opera collaterale, un’iniziativa sovente laica che sorge in particolare in rapporto alla iniziativa missionaria.
Il quadro del rapporto Bibbia-Europa in area protestante sarebbe incompleto se non evocassimo almeno tre fenomeni importantissimi, tipici, che già entrano nell’oggi del nostro discorso e che riguardano naturalmente anche l’area cattolica dell’Europa, ma in modo particolare hanno riguardato in origine e riguardano in parte ancora in maniera specifica il mondo protestante.
Il primo è l’eclisse della Bibbia. Viviamo una grande contraddizione: l’eclisse della Bibbia dalla vita personale e familiare. È un fenomeno all’ordine del giorno nei paesi protestanti (nei paesi cattolici non mi sento di pronunciarmi), è un fatto straordinario, eccezionale, relativamente nuovo.
A fronte di una moltiplicazione di iniziative per rendere conosciuta la Bibbia, di traduzioni in tutte le forme e in tutte le lingue, di fatto, registriamo che è scomparsa quella che, nel protestantesimo, è stata una figura tipica e cioè la Bibbia di famiglia, che diventava poi la Bibbia delle famiglie, la Bibbia che accompagnava una famiglia attraverso molte generazioni (ma sappiamo in quale situazione si trova la famiglia nel mondo moderno). Anche lo studio personale della Bibbia, l’incontro quotidiano con la Bibbia, è molto rarefatto.
Secondo, c’è stata nell’area protestante, oggi anche in quella cattolica, ma è il protestantesimo che è stato il luogo genetico di questo immenso fenomeno, tutta la critica biblica: un’immensa operazione culturale, ma anche spirituale, che tendeva e tende alla valorizzazione della Bibbia (non alla sua relativizzazione). È un fenomeno ancora in corso e continuerà ad esserlo, un fenomeno che caratterizza l’oggi del rapporto Bibbia-Europa.
Il terzo fenomeno che desidero evocare è quasi una risposta polemica o critica nei confronti della critica biblica: il biblicismo, il fodamentalismo biblico. Abbiamo oggi una vastissima area di cristianesimo, soprattutto protestante o di origine protestante, che è biblicista o fondamentalista. Il fenomeno non è tipico del nostro secolo, perché è cominciato prima, ma certamente oggi ha assunto proporzioni ragguardevoli e non è semplicemente un fenomeno marginale.
C’è un terzo punto al quale accennare: l’Europa laica, l’Europa agnostica, quella che in qualche maniera si è sottratta al potere e alla tutela ecclesiastica e in questo modo ha anche praticamente messo da parte la Bibbia. L’Europa laica ha rimosso, oppure snobbato, ignorato, la Bibbia considerandola comunque parte di un universo superato o settoriale.
Abbiamo così il grande paradosso di un’Europa laica che direttamente o indirettamente attraverso rivoluzioni, riforme o evoluzioni, ha affermato una serie di valori e di ideali che sono facilmente riconducibili a matrici bibliche – la libertà, la dignità umana, la giustizia sociale. È una situazione paradossale: l’Europa laica ha proclamato dei valori, degli ideali e li ha incarnati in strutture, leggi, istituzioni che sono diventati – anche senza volerlo – parte della coscienza europea, che non si possono non ricondurre al messaggio biblico,
Ma tutte queste realtà sono state anche affermate senza, o contro, coloro che della Bibbia parlavano in quel tempo. Ecco perché la storia Bibbia-Europa è una storia complessa, contraddittoria, conflittuale, non pacifica: abbiamo la Bibbia diffusa e abbiamo la Bibbia vietata, abbiamo la Bibbia applicata e abbiamo la Bibbia ignorata.
Oggi la Bibbia circola liberamente in tutta Europa anche là dove fino a ieri era vietata come in Albania. La sua diffusione era praticamente paralizzata nei paesi dell’est (la famosa scusa della mancanza di carta) e anche là oggi la Bibbia può circolare e circola. Essa circola dappertutto.
La Bibbia è libera, questo è un fatto nuovo. Anche gli imprimatur che continuano ad esistere sono più formali che sostanziali, non indicano più un controllo, credo, ma semplicemente un quadro. L’imprimatur che pure continua ad esistere, credo abbia un valore molto relativo: non è più censura.
Questa libertà di Bibbia – come la chiamo volentieri – è un fatto nuovo in Europa, non era così ieri. Questa libertà di Bibbia oggi non è soltanto formale, una libertà che tu hai ma non usi; oggi viene usata questa libertà, è una libertà materiale, utilizzata in particolare proprio nel cattolicesimo romano, dove c’è non soltanto una fioritura di studi, perché questo potrebbe anche restare circoscritto all’accademia, per quanto rilevante essa sia.
Anche a livello popolare, a livello di comunità c’è indubbiamente un interesse, e una passione in qualche caso, di lavoro biblico e questo è, secondo me, il fatto più importante da quando c’è stato il Concilio Vaticano II.
Non soltanto la libertà di Bibbia è presente, ma è utilizzata, praticata, materializzata. Questo fatto non potrà non portare a frutto, perché la Parola di Dio non torna a Dio a vuoto, come ben sappiamo.
Il secondo fatto che caratterizza la situazione è l’ecumenicità del lavoro biblico sia a livello di traduzione, sia di spiegazione sia infine, pur con qualche difficoltà maggiore e gradazioni diverse, a livello di diffusione.
Questo carattere ecumenico del lavoro biblico è certo tipico del nostro secolo, dell’oggi del rapporto tra Bibbia e Europa. È un fatto di enorme portata per due ragioni.
La prima è ovvia e cioè che la Bibbia è il principale bene ecumenico della cristianità, oggi. È cioè la realtà condivisa più cospicua che ci sia. Una Bibbia, la stessa Bibbia per tutti.
Ma c’è un secondo punto: la Bibbia stessa è una sorta di scuola vivente di ecumenismo, di ecumenicità.
È un modello di ecumenicità, per riprendere lo slogan dei luterani di “unità nella diversità”: una Bibbia, due Testamenti; un Vangelo quattro redazioni; un apostolato tredici-dodici apostoli; un messaggio, molte voci, compreso, appunto il conflitto e la tensione tra Paolo e Giacomo, ecc.
Ognuno potrebbe parlare a lungo del carattere della Bibbia come luogo in cui si integrano, in cui coesistono, si cercano, si trovano, si riconoscono forme di pietà, di fede, di comunità tra loro molto diverse appunto senza che questa diversità diventi divisione.
Mentre è emblematico il fatto che il lavoro biblico sia ecumenico è anche promettente che la Bibbia a sua volta diventi scuola di ecumenismo per le chiese. Credo che la Bibbia è più ecumenica delle chiese e che il grande sforzo che noi dobbiamo fare è proprio quello di diventare ecumenici almeno come la Bibbia.
Terzo fatto saliente, e questa è una grande sfida, la Bibbia non è più sola in Europa, nel senso di libro della fede, libro religioso per eccellenza, testo sacro. Non è sola.
Come l’Europa è diventata e sta sempre più diventando anche religiosamente pluralista così anche la Bibbia ha perso quella posizione di monopolio più o meno totale che in questi venti secoli essa ha avuto.
La Bibbia oggi ha dei concorrenti, ha dei compagni di strada. Oggi c’è il Corano che sempre più diventa, nella misura in cui cresce la comunità islamica, europea, ma non c’è soltanto il Corano. Ci sono, come sappiamo, molte altre correnti religiose, buddiste, ecc, molti libri dall’oriente e ci sono poi delle specie di bibbie viventi: i vari guru che popolano anche il nostro paese che credono di essere una sorta di rivelazione permanente e personale.
Questo è un fatto che caratterizza la situazione odierna e la rende appunto in qualche modo più problematica.
Quali compiti? Ne indico due in rapida successione. Il primo compito: dobbiamo evitare di confondere la libertà della Bibbia come libro, con la libertà della Bibbia come Parola. Ho parlato volentieri della libertà di Bibbia, ma non vorrei che questo ci inducesse a pensare che la Bibbia come messaggio è libera.
Ci sono molti modi in cui la Bibbia pur essere incatenata, imprigionata e addomesticata. Il pulpito è una specie di simbolo della Bibbia predicata, su ogni pulpito c’è la Bibbia aperta. Ma il pulpito può anche essere il luogo in cui la Bibbia viene addomesticata.
Rientra nella nostra responsabilità di comunità cristiana, far sì che non si identifichi la libertà del libro come libertà della Parola che questo libro attesta. Ecco un compito. Molta Bibbia è tuttora lettera morta nel nostro cristianesimo. Un solo esempio: il famoso Sermone sul Monte, che pure non è certo la parte minore della predicazione di Gesù, finora nella storia della chiesa ha avuto uno strano destino.
In parte è stato “risucchiato” in quella sorta di cristianesimo elitario che è il monachesimo, cioè il Sermone sul Monte sì, ma per qualcuno soltanto, ma certo per noi poveri cristiani qualunque no, è troppo, non possiamo permetterci il lusso di cercare di viverlo.
È soltanto un esempio per indicare come si può incatenare la Bibbia anche semplicemente lasciandola lettera morta. Anche se il libro circola, la lettera muore, la Parola giace: la Bibbia come tomba della Parola di Dio e noi becchini di questa Parola.
Il secondo compito, più arduo, e ci avventuriamo su un terreno molto delicato, minato, è questo: la Bibbia è fatta di Antico e Nuovo Testamento. Credo che dopo duemila anni in cui abbiamo interpretato l’Antico Testamento alla luce del Nuovo, forse è venuto il tempo in cui dobbiamo interpretare il Nuovo alla luce dell’Antico.
Il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento, cioè il nostro rapporto con la Bibbia è stato, a mio giudizio, condizionato dal divorzio tra Chiesa e Israele.
Questo rapporto tra l’Antico e il Nuovo Testamento non lo abbiamo elaborato in una situazione di rapporto positivo con Israele (non dico di identificazione perché siamo cristiani e non ebrei).
Un compito per la cristianità, un compito ecumenico, è appunto quello di ripensare questo rapporto tra i due Testamenti alla luce di un rapporto ricuperato, restituito ad una positività che nel Nuovo Testamento esiste (Romani, capitoli 9 – 11), tra Chiesa e Israele, alla luce del superamento del divorzio tra Chiesa e Israele.
Sarà un bel compito, molto utile per la fede e per la predicazione della chiesa nel mondo
* Paolo Ricca, teologo e pastore valdese, docente emerito di Storia della Chiesa della Facoltà Valdese di Teologia di Roma.