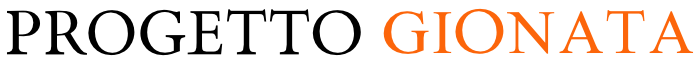Tra misericordia e dottrina: la storia incompiuta di Papa Francesco con le persone LGBTQ+
Riflessioni di Sarah Bricker Hunt* pubblicate sul sito Pridesource.com (Stati Uniti) il 21 aprile 2025. Liberamente tradotte dai volontari del Progetto Gionata.
Papa Francesco è morto il Lunedì dell’Angelo, il 21 aprile, all’età di 88 anni, lasciando dietro di sé un’eredità complessa e controversa, soprattutto per chi, come me, ha vissuto la militanza nella realtà LGBTQ+ e all’interno delle comunità di fede. La sua figura, per noi, ha rappresentato un continuo oscillare tra segnali di apertura e il ripetersi delle esclusioni ecclesiastiche più profonde.
Nel 2013, le sue parole «Chi sono io per giudicare?» rivolte ai sacerdoti omosessuali fecero il giro del mondo, lasciando intuire una possibile svolta. Ma appena due anni dopo, Francesco si oppose con fermezza alla legge sull’identità di genere approvata nel suo Paese d’origine, l’Argentina, definendola «un’iniziativa del demonio» volta a distruggere la famiglia tradizionale.
Durante la sua visita negli Stati Uniti, sempre nel 2015, incontrò privatamente Kim Davis, la funzionaria del Kentucky diventata simbolo dell’opposizione ai matrimoni tra persone dello stesso sesso per essersi rifiutata di rilasciare licenze matrimoniali.
Quell’incontro, tanto pubblico quanto simbolico, fu un duro colpo per molte persone LGBTQ+ credenti, che fino a quel momento avevano coltivato la speranza in una Chiesa più accogliente.
Eppure, nel 2020, Francesco sorprese di nuovo il mondo dichiarandosi a favore delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso – una posizione senza precedenti per un Papa. Ma anche in quell’occasione, accanto all’apertura, riaffermò la contrarietà della Chiesa al matrimonio egualitario e all’adozione da parte di coppie omosessuali.
Nel 2021, le sue affermazioni secondo cui le persone transgender non dovrebbero essere ammesse nei seminari ci riportarono alla dura realtà dei limiti del suo approccio. Per quanto parlasse di inclusione, le mura dottrinali restavano intatte.
A livello globale, il suo pontificato ha creato un paesaggio ambivalente: parole contro la discriminazione si accompagnavano a dichiarazioni che rafforzavano le barriere. Nel 2019, definì la teoria del gender una «guerra mondiale contro la famiglia», pur avendo precedentemente invitato alla compassione verso le persone LGBTQ+.
Quando il cardinale Kevin Farrell annunciò la morte di Francesco parlando del suo «amore universale», quelle parole suonarono in modo diverso alle orecchie di chi, come me, si è sentito accolto solo a metà. Perché quell’amore, per molte persone LGBTQ+ cattoliche, è stato spesso condizionato, e mai pienamente riconosciuto.
Nel 2023, ci fu un gesto che sembrò rompere davvero gli schemi: Papa Francesco prese posizione contro la criminalizzazione dell’omosessualità, definendo ingiuste le leggi che puniscono le persone in base al loro orientamento. Durante un’intervista con l’Associated Press e una conferenza stampa in volo, denunciò apertamente tali norme, invitando i vescovi che le sostenevano a un «processo di conversione».
Ricordò che, sebbene la Chiesa continui a ritenere peccaminosi i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, condannare le persone per ciò che sono è di per sé un peccato. «Le persone con tendenze omosessuali sono figli di Dio», disse, e quelle parole portarono sollievo, seppur momentaneo.
Poco prima della sua morte, però, la delusione tornò. In un incontro a porte chiuse, Francesco utilizzò un’espressione volgare e omofoba parlando dei sacerdoti omosessuali. Il clamore mediatico lo costrinse a scusarsi. Il portavoce vaticano, Matteo Bruni, dichiarò che il Papa «non intendeva offendere né esprimersi in termini omofobi». Ma il danno era ormai fatto.
Natalia Imperatori-Lee, docente di studi religiosi al Manhattan College, colse bene l’essenza della questione: «Più delle parole offensive, ciò che fa male è l’insistenza della Chiesa cattolica nell’escludere gli uomini gay dal sacerdozio, come se non sapessimo – o non collaborassimo già – con tanti sacerdoti omosessuali, celibi e straordinariamente capaci».
Mentre la Chiesa Cattolica si prepara a eleggere un nuovo Papa, chi, come me, ha cercato di restare nella Chiesa con onestà e dignità, si trova davanti a un’eredità fatta di mezze aperture e di dolorose chiusure.
Francesco ha aperto spazi di dialogo, ma non ha mai abbattuto i muri. Ha portato un linguaggio più umano, ma ha lasciato intatte le strutture che ci respingono.
La sua storia con le persone LGBTQ+ resta, purtroppo, una storia incompiuta.
*Sarah Bricker Hunt è una giornalista americana specializzata in religione, giustizia sociale e diritti civili. Scrive per Religion News Service e altre testate internazionali.
Testo originale: Between Mercy and Doctrine: Pope Francis’s Unfinished LGBTQ+ Story