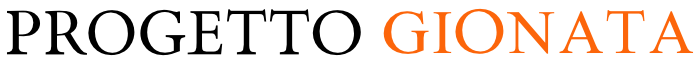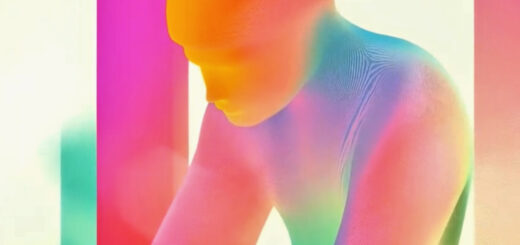Queer theology and epistemological doubt: "How do we know what we know?"
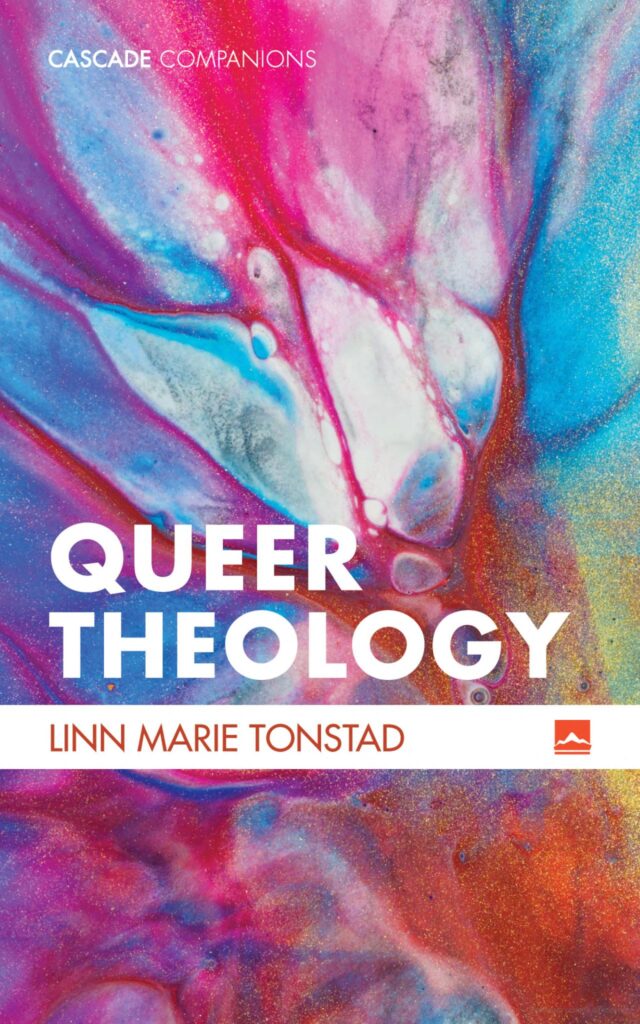
Riflessioni di Anna Nekola, pubblicato su Direction: A Mennonite Brethren Forum (Canada), vol.49, n. 2, autunno 2020, pp.211–213. Liberamente tradotte dai volontari del Progetto Gionata
"Nella prima lezione del mio corso di Teoria Queer, dico sempre agli studenti che esploreremo il concetto di “normalità”, chiedendoci come certe idee siano diventate così potenti da essere considerate di senso comune indiscusso. In altre parole, dobbiamo domandarci: come sappiamo ciò che sappiamo?” (Linn Marie Tonstad)
Nel saggio Queer Theology: Beyond Apologetics (2018. 159 pagine) Linn Marie Tonstad, professoressa associata presso l’Università di Yale, applica le intuizioni della teologia queer alla teologia cristiana, argomentando con convinzione che i cristiani dovrebbero “pensare in modo queer”, investigando la formazione delle norme e mettendo in discussione le strutture di potere che plasmano, spesso invisibilmente le idee sociali e religiose di chi appartiene a cosa e di chi no.
Questo libro è un ottimo punto di partenza per chi vuole partecipare a discussioni sul rapporto tra genere, sessualità, disuguaglianza e strutture di potere nella vita dei cristiani e delle istituzioni cristiane. Attraverso la storia e la teologia, si condividono alcune idee chiave della teologia queer: una consapevolezza dell’intreccio tra cristianesimo e sistemi politici, e il desiderio di lavorare per la riconciliazione. Guardare il mondo attraverso una lente queer può aiutarci a riconoscere la ricca diversità dell’esperienza umana e a sviluppare maggiore compassione verso noi stessi e accettazione per gli altri.
“Queer Theology: Beyond Apologetics” di Linn Marie Tonstad
inizia con un’analisi della conoscenza e della normalizzazione. Secondo Tonstad, le nostre idee su sesso e genere hanno una storia, e quelle cristiane derivano non solo dalla Bibbia, ma anche dalle visioni di peccato, identità e corpo di pensatori influenti come Agostino (ossessionato dalla sua corporeità indisciplinata), Cartesio (che modernizzò la dualità corpo-mente) e Aristotele e Tommaso d’Aquino, che consideravano le donne “uomini difettosi”.
Nel secondo capitolo, Tonstad esamina le strategie apologetiche adottate per includere le persone LGBTQIA+ nelle istituzioni cristiane. Tra le domande poste: Dio deve essere concepito entro un sistema di differenza di genere eterosessuale? Esisterà il genere in paradiso? Se tutti nasciamo peccatori, alcuni peccati sono peggiori di altri?
Tonstad dimostra come i dibattiti cristiani su genere e sessualità spesso riducano la complessità dell’umanità. Tuttavia, sostiene che una teologia queer dovrebbe andare oltre l’apologia e la semplice inclusione.
Il terzo capitolo esplora le possibilità di una teologia queer, criticando le categorie dualistiche e i sistemi normativi. Secondo Tonstad, i cristiani devono riconoscere che le loro visioni normative sono legate a strutture gerarchiche di significato e di potere. Basandosi su teologhe come Marcella Althaus-Reid, Tonstad propone una teologia queer che si confronti con i sistemi socioeconomici e sessuali diseguali.
Nel quarto capitolo, “Denaro, sesso e Dio”, Tonstad mostra come una teologia queer possa smascherare le dinamiche di oppressione legate al capitalismo, alla famiglia nucleare e agli stati colonialisti. Questa teologia non si limita a chiedere inclusione, ma sfida ingiustizie e disuguaglianze.
Nonostante alcune ambiguità nel capitolo finale, dove le domande restano aperte, lo stile chiaro e accessibile di Tonstad rende il testo adatto anche a lettori universitari meno esperti, senza sacrificare la profondità delle idee.
*Anna Nekola è professoressa presso la Canadian Mennonite University di Winnipeg, Manitoba (Canada)
Original text: Queer Theology: Beyond Apologetics