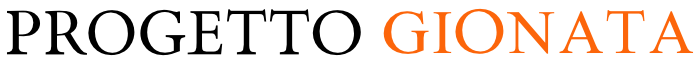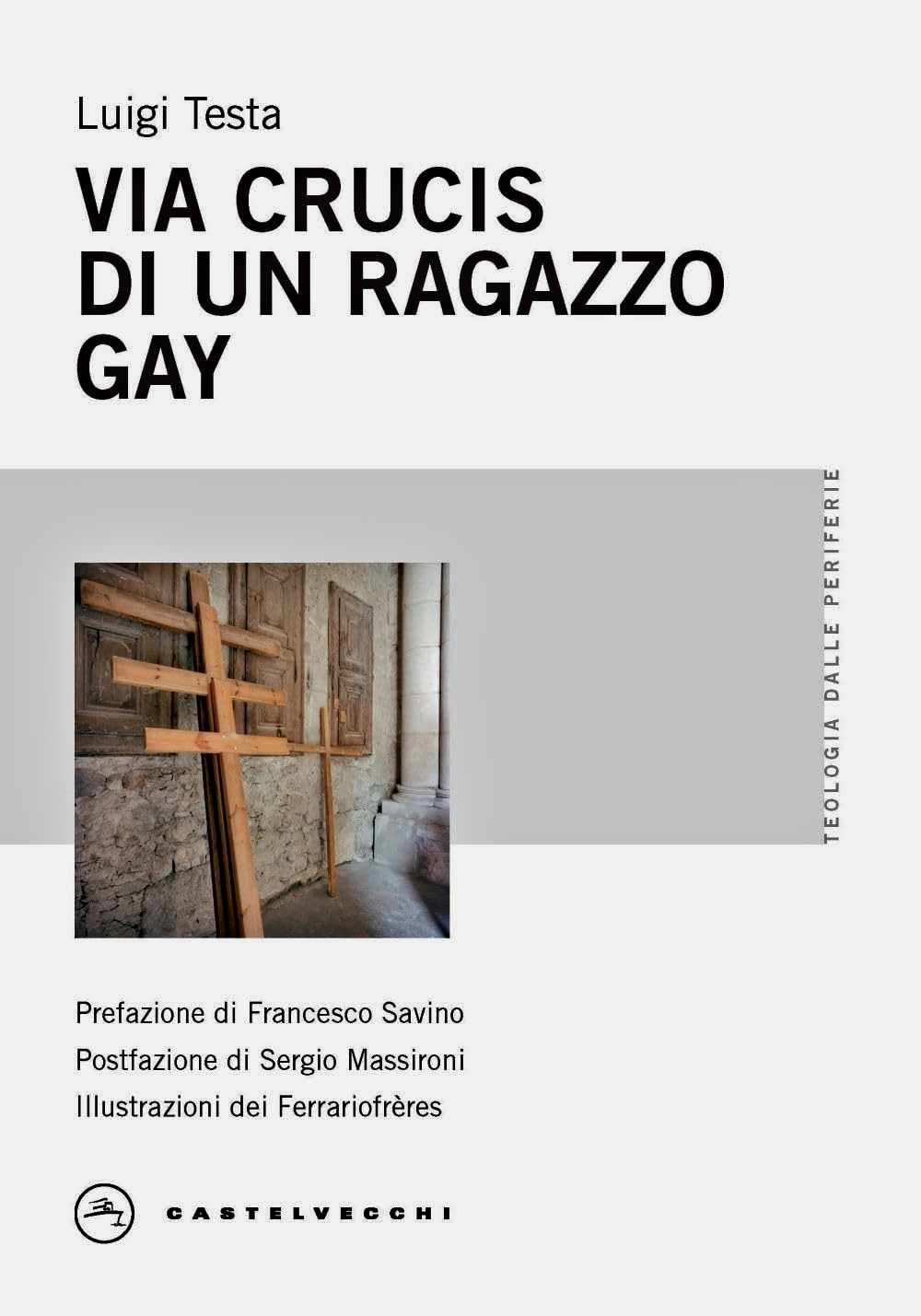La croce che resta sulla pelle
Intervento tenuto da Mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vice Presidente della CEI, alla presentazione del libro “Via crucis di un ragazzo gay” di Luigi Testa nella Parrocchia San Giuseppe di Roma il 4 aprile 202
Esistono trame esistenziali che non si limitano a raccontare una vita, ma la espongono. Non per esibizionismo, né per bisogno di consenso, ma per necessità interiore, per urgenza spirituale. Sono narrazioni che squarciano la tela dell’invisibilità e decidono di abitare la verità, qualunque sia il prezzo da pagare. Via Crucis di un ragazzo gay di Luigi Testa (Castelvecchi, 2024) è uno di questi resoconti dell’anima: una via percorsa non per imitazione, ma per liberazione.
In questo libro non c’è la maschera della devozione stereotipata, né l’alibi di una spiritualità disincarnata. Testa prende su di sé l’intera tradizione cristiana – il linguaggio, i simboli, le ferite – e la riconsegna al lettore con una voce ferma e potente, senza sconti e senza veli. È una parola che nasce dalla ferita, ma che non si riduce al dolore.
Una parola che cerca senso, redenzione, luce. Il gesto più radicale del testo è la scelta di non nascondersi più.
L’autore nomina la sua omosessualità e la assume come parte integrante del proprio cammino spirituale. Non la presenta come una tentazione da combattere, né come una condizione da sopportare, ma come un respiro segreto dell’anima, parte viva della sua identità più profonda, che attende di essere ascoltata, onorata, accolta.
Questo posizionamento, che può sembrare “semplice” o addirittura “ovvio” agli occhi di chi vive lontano dalla dimensione ecclesiale, è nella Chiesa cattolica un atto di coraggio profetico, specie in un contesto come quello italiano, dove l’omosessualità vissuta cristianamente è ancora spesso accompagnata da silenzi, ambiguità, paure, compromessi interiori.
Le stazioni della Via Crucis diventano allora il dispositivo narrativo per raccontare una passione che non è solo quella del Cristo, ma anche quella del giovane che agli occhi degli altri ama “nel modo sbagliato”: del figlio giudicato, del catechista non più accolto, del seminarista costretto all’uscita silenziosa, del fedele che ogni domenica siede nell’ultimo banco della chiesa, temendo che la sua sola presenza possa turbare l’equilibrio degli “accettati”.
Nel libro, è sin dall’inizio che il respiro dell’autore si fa confessione e ferita: «Sono morto dentro tante volte anche io, Gesù, quando una parola leggera mi ha condannato. Quando una confidenza tradita mi ha svelato».
Il dolore non arriva da un evento eclatante, ma da quel lento logoramento quotidiano che si consuma nei rapporti più intimi, nei gesti più familiari.
Nemmeno la condanna ha bisogno del clamore: basta uno sguardo, una frase lasciata cadere, una preferenza taciuta. La croce, in questo libro, pesa di parole non dette, delle carezze negate, delle omelie ambigue, delle benedizioni mai concesse.
È il peso di un amore che viene continuamente posto sotto inquisizione, ma è anche – e qui sta la forza del testo – lo spazio in cui quella stessa croce viene trasfigurata.
Perché la spiritualità che emerge da queste pagine è ferita, sì, ma non rassegnata. E’ una fede ferita e tenace, che ha attraversato il deserto dell’abbandono, che ha tremato al pensiero di non poter essere mai abbracciata da Dio. Ma è anche un affidarsi che ha imparato ad ascoltarsi, a resistere, a gridare. Un atto di fiducia che rivendica il diritto di esistere.
Da un punto di vista sociologico, Via Crucis di un ragazzo gay ci restituisce un ritratto profondo e drammaticamente realistico delle forme di marginalizzazione che ancora oggi attraversano la vita delle persone LGBTQ+ nei contesti religiosi e familiari.
Luigi Testa racconta senza retorica la vergogna interiorizzata, l’autocensura appresa, il senso di colpa strutturale che si annida in chi cresce sentendosi “fuori norma” in ambienti che fanno dell’adesione alla norma il presupposto dell’amore. Quel corpo ha dovuto farsi piccolo, invisibile, spiritualmente neutro per non disturbare, per non deludere, per non essere “di scandalo”.
Lo racconta con una dolcezza disarmata: «La prima volta che ho fatto coming out, Signore, è stato per chiedere aiuto. […] In tutti i coming out che ne sono seguiti, mi son sentito sempre più scarico, sempre più leggero».
E’ il linguaggio di chi ha trovato il coraggio di nominare la sua verità più intima, e nel farlo ha sperimentato non la condanna, ma il sollievo. Come se dire fosse già liberazione, come se raccontarsi fosse già salvezza.
Tra le pagine più dolorose, il rifiuto che scava nel cuore è quello vissuto dentro le mura di casa. Scrive Testa: «Chi si sente giudicato, dai genitori, si sente cacciato via; chi dai genitori non si sente amato, si mette da solo sulla strada di questi genitori. […] Mettiti sulla strada e sciogli le incrostazioni dei cuori».
E’ il grido di chi ha dovuto fare i conti con l’assenza di uno sguardo d’amore, con il gelo che si insinua là dove ci si attendeva abbracci. E la fede, anche qui, non salva scappando: salva attraversando. Ma questa Via Crucis non si arresta al travaglio interiore.
Il libro è anche un atto politico – nel senso più alto del termine – perché rivendica il diritto alla parola, alla presenza, all’esistenza piena. Come quando scrive, senza artifici e senza accuse: «Tutte le volte in cui qualcuno mi dice che non merito, tutte le volte in cui qualcuno mi vuol convincere che sono sbagliato […] la tua morte in croce è bestemmia».
E’ in questa frattura – tra il senso di indegnità e la croce come rifiuto di ogni norma – che la spiritualità di Testa si fa più acuta e rivelatrice: la sua fede nasce dal punto esatto in cui l’amore viene negato.
È una spiritualità che chiede cittadinanza. Una fede che non vuole essere relegata a spazi protetti e silenziosi, ma desidera stare in mezzo alla comunità, tra gli altri, con gli altri, senza che la propria differenza sia percepita come un’incrinatura dell’ordine.
Qui emerge un secondo livello di riflessione, più silenzioso e come nella filigrana del testo, ma altrettanto potente: la Chiesa, oggi, è capace di ascoltare storie così? È ancora in grado di lasciarsi interpellare non solo dalla dottrina, ma dai corpi concreti, dalle lacrime vere, dalle preghiere che nascono non dalla perfezione, ma dalla ferita?
Luigi non chiede una benedizione formale. Chiede che la sua fede, e quella di tanti come lui, non sia continuamente posta sotto esame. Reclama che l’amore non sia tollerato, ma riconosciuto. Che la spiritualità di una persona omosessuale non sia sempre un ‘caso’ da studiare o correggere, ma una delle tante vie, profonde e sincere, attraverso cui l’uomo si mette in cammino verso il Mistero.
Lo ha fatto, con delicatezza e tenacia, ristrutturando i legami e perfino i dolori presso la croce. E’ lı̀ che l’amore non più conforme diventa memoria di redenzione.
E in questo senso Via Crucis di un ragazzo gay è una delle testimonianze più autentiche e necessarie nel panorama attuale, perché osa dire ciò che spesso è lasciato ai margini: che anche le vite spezzate, rifiutate, silenziate, sono già dentro il mistero pasquale. Che anche i corpi non conformi portano in sé i segni della resurrezione.
La modalità con cui Testa intreccia la via crucis e la sua esperienza di vita restituisce un punto di accesso nuovo, più leggero, intimo, come un giardino d’amore che non divide ma unisce. In un tempo in cui anche la fede viene spesso polarizzata, questa è una lezione teologica e umana: il dolore condiviso può diventare un ponte, non una barriera.
E proprio nel finale, nel giardino simbolico dell’incontro ritrovato, Testa sussurra parole che sembrano venire da un’altra vita – o forse dalla vita che tutti desideriamo: «Ora che sono arrivato alla fine, tienimi con te. […] Ti toccherò, invece. Ti tratterrò. Non mi allontanerò, e resteremo insieme per sempre nel giardino della resurrezione».
E’ un’ultima immagine di intimità, non più trattenuta né colpevolizzata: amore che si può dire, che si può toccare, che può restare. Come a dire che anche la pena può trovare consolazione, e che anche chi ha molto amato – e molto sofferto – può finalmente abitare la luce.
Questa recensione è in realtà solo l’inizio di un ascolto. A un certo punto, le parole del critico devono lasciare spazio alla sensibilità del pastore. E lo faccio, ora, con umiltà e con tremore.
Sono un vescovo. E come tale non posso leggere Via Crucis di un ragazzo gay senza sentirmi interpellato profondamente. Non come studioso, non solo come credente, ma come padre e fratello nella fede.
Le pagine del narratore mi hanno toccato. Non perché raccontano qualcosa di nuovo, ma perché hanno il coraggio di dire ad alta voce ciò che in molti – troppi – sono costretti a vivere in silenzio. Non è la verità di queste vite a spaventarmi, ma il nostro silenzio che le rende invisibili.
Per troppi anni abbiamo parlato sull’omosessualità, raramente con le persone omosessuali. Abbiamo elaborato documenti, pronunciato omelie, costruito catechismi. Ma non sempre abbiamo saputo ascoltare. E ascoltare è un atto di coraggio: non basta udire, occorre lasciarsi toccare nel punto più vulnerabile.
Lasciarsi raggiungere nel profondo. Comprendere che dietro ogni storia come quella di Luigi c’è un grido di dignità che non può più essere ignorato, e una fede che – pur non trovando sempre casa nella comunità – continua a cercare Dio con sincerità struggente.
E’ lui stesso a dirlo con parole che inchiodano: «Se non so amarmi, se non so accettarmi, se non so volermi bene, è perché non sto fermo lì, sotto la croce, mentre tu mi guardi, e mi dici: “È per te”». E’ una confessione disarmata, ma anche una supplica: quella di chi cerca uno sguardo che non lo giudichi, ma lo benedica. Che non lo cambi, ma lo accolga.
Questa Via Crucis è anche la nostra. La mia. È la via che percorre ogni comunità cristiana quando sceglie di non voltarsi dall’altra parte, quando si lascia destabilizzare dalle domande che emergono dai margini. Quando non ha paura di sporcarsi le mani con l’umanità reale.
Come vescovo, non mi interessa difendere confini, ma custodire volti. E il volto di chi ama, crede, spera e soffre non può essere tenuto fuori dal cuore della Chiesa. Non può essere escluso dalle sue benedizioni, né dalle sue liturgie interiori. Non si tratta di cambiare la dottrina, ma di purificare lo sguardo. Di tornare a quel Gesù che ha sempre scelto di stare dalla parte dei corpi feriti, dei cuori disprezzati, delle storie negate.
La posizione della Chiesa sull’affettività e la sessualità, se vuole essere realmente evangelica, non può ridursi a formule normative o moralistiche. Deve partire dalle storie, dai volti, dalle relazioni. Non esiste verità cristiana che possa germogliare se non è innestata nell’ascolto della persona concreta, nella sua sete d’amore e di senso.
Karl Rahner – per me il più grande teologo cattolico del Novecento – ci ha insegnato che “la realtà ultima dell’uomo è il suo essere una domanda infinita rivolta a Dio”. E se l’essere umano è domanda, ricerca, tensione verso il Tu, allora nessuna condizione affettiva può essere trattata come un’anomalia. L’omosessualità non è una deviazione dalla grazia, ma un luogo – spesso oltraggiato – in cui la grazia può manifestarsi, visitare, salvare.
A questa visione fa eco la parola sofferta e luminosa di Henri Nouwen, sacerdote e psicologo, che ha vissuto in silenzio la propria omosessualità mentre scriveva parole di struggente umanità: «Nessuno può offrire ospitalità vera se non ha conosciuto il proprio deserto interiore».
L’accoglienza dell’altro – soprattutto quando è fragile, esposto, spinto nell’ombra – non è un’opzione per la Chiesa, ma è il suo battesimo quotidiano. Ed è proprio lì, nel gesto che non giudica ma abbraccia, che si manifesta la somiglianza con il Dio che ha preso carne nei nostri limiti. Per questo credo, con convinzione profonda, che la vera ortodossia non sia la rigidità, ma la compassione intelligente.
L’insegnamento morale non può diventare uno strumento per opprimere chi già porta su di sé il peso del rifiuto. Se vogliamo essere Chiesa, allora dobbiamo imparare a guardare non soltanto alla conformità di un amore alla norma, ma alla sua fedeltà alla verità di una persona che cerca Dio con tutta sé stessa. E quando è cosı̀, forse siamo già sul terreno sacro dell’incontro.
L’amore, ogni amore che nasce dal rispetto e si nutre di dono, è sempre più vicino al Vangelo di quanto pensiamo. E forse, se tornassimo a guardare ogni storia come luogo teologico, scopriremmo che Dio ha dimorato a lungo proprio nei cuori che avevamo escluso. In questa luce, l’omosessualità non è uno scarto della creazione, ma una forma di esistenza che chiede ascolto, accompagnamento, riconoscimento. La Chiesa non deve avere paura di camminare accanto a chi ama. Non si tratta di negare la tradizione, ma di lasciarla evolvere dentro le pieghe della misericordia.
Ogni volta che ci siamo irrigiditi su categorie morali, abbiamo smesso di vedere i volti. Ogni volta che abbiamo parlato sull’altro invece che con l’altro, abbiamo tradito il Vangelo dell’incontro.
E allora oggi, più che mai, sento che il primo atto teologico della Chiesa è l’abbraccio. Il secondo è l’ascolto. Il terzo è il silenzio adorante davanti al mistero dell’altro.
Il resto – la dottrina, i documenti, le norme – viene dopo. Perché prima di tutto viene la persona. E in ogni persona abita un frammento del volto di Dio.
Il libro di Luigi Testa ci consegna una domanda che non possiamo eludere: saremo capaci di costruire una Chiesa che non abbia paura dell’amore? Io voglio sperare di sì. E voglio farlo a partire da questo gesto di testimonianza che non giudica, ma offre. Che non pretende, ma si dona. Una testimonianza che ci chiede solo di restare, di non fuggire, di accompagnare. Di essere finalmente quella casa in cui nessuno debba più sentirsi ospite di passaggio, ma figlio amato.
Che questa Via Crucis possa diventare, per tutti noi, una via di luce. E che la resurrezione promessa non sia solo per il domani, ma cominci – con gesti concreti – oggi.
Perché l’amore, quando è autentico, è sempre un gesto di nardo versato: «spezzato, sparso, sprecato», scrive la postfazione. L’audacia del protagonista spirituale del testo è tutta qui: «tocca, unge, accarezza, non spiega».
E forse è questa la tenerezza che la Chiesa deve ancora imparare: quella che non ha paura del corpo, dell’intimità, del profumo che resta sulla pelle.