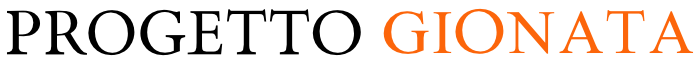La comunità LGBTQ+ e l’abuso spirituale: un trauma invisibile
Articolo di Amanda Hildreth* pubblicato sul sito di Abuse Refuge.org (Stati Uniti) il 26 agosto 2023, liberamente tradotta dai volontari del Progetto Gionata
Gli atteggiamenti delle chiese cristiane verso le persone LGBTQ+ possono variare enormemente, sia all’interno delle loro comunità che nei confronti dell’esterno. Quando una persona LGBTQ+ appartenente a una comunità religiosa fa coming out, le reazioni possono andare dall’accoglienza piena fino all’ostracismo più severo.
Molte persone LGBTQ+ trovano un senso di benessere e sostegno in ambienti religiosi inclusivi. Tuttavia, molte altre affrontano esperienze negative legate alla religione che continuano a influenzarle anche molto tempo dopo aver lasciato ambienti religiosi non accoglienti.
Che cos’è l’abuso spirituale e come colpisce le persone LGBTQ+
Le ricerche mostrano che le persone LGBTQ+ che frequentano chiese cristiane possono spesso essere vittime di abuso spirituale (Spiritual Abuse) e soffrire di traumi legati a esperienze religiose negative (Barnes & Meyer, 2013; Cole & Harris, 2017; Gandy-Guedes et al., 2017; Gibbs & Goldbach, 2020). Il trauma religioso è una forma di danno psicologico che nasce da messaggi, credenze o esperienze legate alla religione (Stone, 2013).
Le persone LGBTQ+ possono vivere molteplici forme di trauma spirituale, spesso legate a comportamenti o imposizioni da parte di responsabili religiosi e comunità. Alcuni esempi includono:
Essere smascherati senza il proprio consenso: genitori o coetanei possono rivelare la loro identità a responsabili religiosi con l’intento di “salvarli” o nella speranza che cambino il proprio orientamento sessuale o identità di genere.
Essere accusati di eventi negativi: si attribuisce loro la responsabilità di malattie, incidenti o altre sventure, come conseguenza del loro essere LGBTQ+.
Subire terapie di conversione: interventi di pastori o medici volti a modificare l’identità sessuale o di genere, spesso con esiti profondamente dannosi.
Essere costretti a rituali religiosi: partecipare a pratiche volte a “purificare” la loro identità o orientamento sessuale.
Demonizzazione: essere definiti come posseduti da demoni o identificati con il male a causa della loro sessualità.
Esclusione da ruoli di responsabilità: sentirsi dire che non possono ricoprire incarichi nella chiesa a causa della loro identità di genere.
Rifiuto nei sacramenti: non essere accettati in riti fondamentali come il matrimonio o non avere riconosciuta la propria relazione.
Anche se gli abusi più evidenti sono quelli che attirano maggiormente l’attenzione, è essenziale riconoscere che molte persone LGBTQ+ vivono traumi religiosi in silenzio per anni, spesso senza comprendere pienamente il loro impatto (Miriam Geiger, 2023).
Come riconoscere i segnali di abuso spirituale
L’abuso spirituale si manifesta in modi diversi, attraverso atteggiamenti e comportamenti che minano il benessere mentale ed emotivo di una persona. Secondo Change, Inc. St. Louis Counseling (2015), i segnali più comuni includono:
Domande viste come ribellione: Fare domande o esprimere dubbi sulle pratiche religiose viene percepito come un attacco all’autorità spirituale, scoraggiando il pensiero critico
Pensiero rigido e senza sfumature: Si promuove un modo di pensare basato su regole inflessibili: o sei dentro e accetti tutto, o sei fuori e vieni considerato un peccatore
Discriminazione aperta o nascosta: Si osservano comportamenti disuguali verso donne, persone di colore e persone LGBTQ+, spesso giustificati da interpretazioni distorte delle scritture
Isolamento sociale: Le persone al di fuori della comunità vengono trattate come minacce, portando chi ne fa parte a temere e isolarsi dal resto del mondo
Contraddizioni tra parole e azioni: I responsabili religiosi o le comunità possono agire in modo opposto ai valori che professano, creando confusione e perdita di fiducia
Dissentire è peccato: Esporre dubbi o difficoltà personali viene visto come un comportamento peccaminoso, spingendo le persone a reprimere le proprie emozioni
Negazione dei problemi di salute: Questioni di salute mentale o fisica vengono ignorate, considerate peccati o addirittura responsabilità della persona stessa
Controllo tramite paura e vergogna: La comunità manipola i suoi membri facendo leva sulla paura della punizione divina o sull’umiliazione pubblica
Abusi giustificati o ignorati: Comportamenti abusivi da parte di responsabili religiosi – fisici, emotivi o verbali – vengono tollerati o giustificati, perpetuando un ciclo di sofferenza
Le conseguenze a lungo termine sulle persone LGBTQ+
Le esperienze di abuso religioso possono avere un impatto devastante sulla salute mentale e spirituale delle persone LGBTQ+.
Negazione di sé e repressione della sessualità: Molte persone LGBTQ+ cresciute in ambienti religiosi ostili si trovano a dover reprimere i propri sentimenti, rinunciando a vivere la propria sessualità in modo autentico. Questo conflitto interno porta spesso a sofferenze psicologiche significative (Beagan & Hattie, 2015; Jones, Power e Jones, 2022; Page et al., 2013).
Salute mentale e depressione: Uno studio ha rilevato che il 68% delle persone LGBTQ+ che hanno vissuto conflitti tra identità sessuale e credenze religiose riporta livelli significativi di depressione. Il 25% ha avuto pensieri suicidi, e il 29% ha tentato il suicidio (Subhi & Geelan, 2012).
Strategie di coping dannose: Il termine “coping” si riferisce ai meccanismi che una persona utilizza per affrontare situazioni di stress o sofferenza. Quando però queste strategie diventano distruttive, il disagio può aumentare.
Per esempio, molti uomini gay ortodossi ebrei raccontano di essersi sposati con partner del sesso opposto per nascondere la propria identità o di aver partecipato a rituali religiosi per tentare di eliminare il “peccato” di essere gay (Itzhaky & Kissil, 2015). Questi comportamenti, anziché alleviare il dolore, lo amplificano, creando un senso di isolamento e disperazione.
Microaggressioni e isolamento: Le persone LGBTQ+ possono subire microaggressioni nelle chiese sotto forma di commenti, atteggiamenti o comportamenti che le fanno sentire minacciate, indesiderate o escluse. Questo può portare a danni duraturi al loro benessere psicologico e spirituale, alimentando il senso di solitudine e di lutto per relazioni e comunità perdute (Hollier et al., 2022).
Come superare l’abuso religioso: Affrontare gli effetti dell’abuso religioso richiede tempo, consapevolezza e il giusto supporto. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare un percorso di guarigione (Powell, 2021):
Riconosci l’abuso: È fondamentale smettere di giustificare il comportamento dell’abusante e riconoscere che ciò che è accaduto è stato sbagliato, indipendentemente dalle intenzioni dichiarate
Cerca supporto: Parla con persone di cui ti fidi – familiari, amici o terapeuti specializzati – e considera di unirti a gruppi di supporto al di fuori delle credenze religiose
Stabilisci confini sani: L’abuso religioso spesso implica una violazione dei confini personali. Lavora per riprendere il controllo sulle tue scelte e proteggerti da ulteriori danni
Sappi che non sei solo: Il trauma che hai vissuto non è una tua colpa né un riflesso della tua capacità di affrontare le difficoltà. Con il giusto supporto, puoi superare il dolore e riscoprire la tua autenticità
* Amanda Hildreth è una terapeuta di Abuse Refuge.org (ARO) un’organizzazione no-profit con sede in Ohio, USA, che offre supporto e risorse alle vittime e ai sopravvissuti di vari tipi di abuso. La loro missione è offrire un “rifugio” e un percorso di guarigione per loro attraverso programmi educativi e terapeutici.
Testo originale: The lgbtq+ community and religious abuse: trauma unseen
>Ai bisogno di aiuto o di ascolto? Contatta il servizio di ascolto “Mi fido di Te”, alla mail mifidodite@gionata.org per organizzare un colloquio via telefono o una videochiamata.